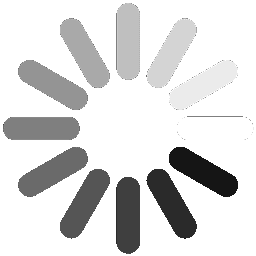Diritti negati. Paghe da fame. Danni all'ambiente. E i grandi marchi che se ne approfittano. Nei Paesi da cui importiamo i nostri abiti, spesso i lavoratori sono ancora sotto ricatto. Malgrado tutti gli accordi internazionali. Ma la catena dello sfruttamento arriva anche in Italia.
Articolo di Andrea Lanzetta, pubblicato su TPI 21-27/aprile/2023
Lavorano anche undici ore al giorno, sono giovani, spesso donne – pagate meno dei loro colleghi maschi – o persone emigrate da zone povere o arrivate dall’estero. Il modello economico alla base della cosiddetta moda ultra-veloce, caratterizzata da capi di scarsa qualità, venduti a prezzi bassi e con cicli di vita brevi, si fonda in molti casi sullo sfruttamento dei lavoratori e dell’ambiente, al solo scopo di aumentare i profitti. Tutto questo malgrado gli accordi internazionali raggiunti dopo la tragedia del Rana Plaza, in Bangladesh, che hanno certamente migliorato la situazione ma che per ora non hanno risolto i problemi di una filiera dei diritti negati a cui, purtroppo, nemmeno l’Italia sembra estranea.
Alla radice del problema
Tutto comincia nei principali Paesi da cui importiamo i tessuti utilizzati per produrre i nostri abiti e da dove spesso arrivano i nostri stessi vestiti. Parliamo di una manciata di nazioni: secondo la Banca mondiale, oltre il 75% dei prodotti tessili e dei capi d’abbigliamento importati nell’Unione europea arriva da Cina, Bangladesh, Turchia, India, Pakistan e Cambogia, una percentuale che – stando alla Farnesina – scende ma resta oltre il 51% persino in Italia, dove la nostra produzione si concentra ancora sull’Alta Moda e non sul fenomeno Fast Fashion.
Ma lo sfruttamento inizia già con la lavorazione delle materie prime, a partire da cotone e pellame. La Cina è il primo esportatore mondiale di filati e il 90% del cotone cinese arriva dalla provincia dello Xinjiang, dove Pechino è accusata di opprimere la minoranza musulmana turcofona degli uiguri che, secondo un progetto di ricerca dell’Australian Strategic Policy Institute (Aspi), sarebbe addirittura costretta a lavorare nei campi e nelle fabbriche tessili, mascherate da istituti professionali in cui milioni di persone sarebbero ridotte in semi-schiavitù. Il secondo esportatore mondiale è invece l’India, dove la produzione maggiore di filati avviene in Tamil Nadu. Qui, nonostante le leggi locali impongano una giornata lavorativa non superiore alle 6 ore, si arriva a lavorare anche 10 o 12 ore con retribuzioni inferiori ai 2 dollari al giorno. Un problema esteso anche alla Turchia, dove negli ultimi anni diverse organizzazioni umanitarie hanno denunciato l’impiego in fabbriche tessili illegali di rifugiati siriani – anche minorenni – pagati meno di 120 euro per 60 ore settimanali.
E non va meglio in Brasile, il secondo esportatore mondiale di pellame dopo la Cina e tra i primi da cui l’Italia acquista pelli e cuoio, dove sono stati documentati casi di sfruttamento, lavoro forzato e terre sottratte agli indigeni a scopo di allevamento, soprattutto a danno delle comunità dell’Amazzonia, già falcidiata dall’inquinamento.
I danni della moda ultra-veloce si estendono infatti anche all’ambiente: secondo uno studio di McKinsey, solo nel 2018, il settore ha prodotto circa 2,1 miliardi di tonnellate di emissioni di gas serra, pari al 4% del totale globale. Senza contare l’apporto di rifiuti: stando a una relazione Onu del 2019, «ogni secondo viene sepolta o bruciata una quantità di tessuti equivalente a un intero camion di spazzatura», mentre per Greenpeace, entro il 2030 l’industria tessile genererà 102 milioni di tonnellate di scarti ogni anno. Per avere un’idea del danno, basta recarsi nel cosiddetto “cimitero della moda”, una serie di discariche a cielo aperto ad Alto Hospicio, nel deserto cileno di Atacama, dove finiscono migliaia di tonnellate di vestiti invenduti.
Eppure, una soluzione parrebbe esserci per entrambi i problemi. Secondo l’esperto statunitense Roland Geyer, docente di Ecologia industriale presso la University of California – Santa Barbara e autore del libro “The Business of Less”, «la chiave della sostenibilità sociale e ambientale risiede nel lavoro, piuttosto che nei prodotti o nei materiali green». A partire dal salario minimo: secondo il docente, pagare stipendi dignitosi e rendere le condizioni di lavoro più umane contribuirebbe a “far rallentare” la moda ultra-veloce, riducendo le emissioni inquinanti. Un esempio? Geyer calcola che un aumento di 400 dollari del salario mensile dei 35 milioni di lavoratori del tessile in tutto il mondo taglierebbe immediatamente di oltre 65 milioni di tonnellate le esalazioni globali di CO2. La realtà sul campo però è ben diversa e purtroppo non è stata (ancora) scalfita dai più recenti accordi internazionali.
Condizioni migliori?
Il caso più eclatante riguarda le condizioni di lavoro rilevate nei fornitori del colosso cinese Shein. Secondo un’indagine condotta nel 2021 da Public Eye in 17 fabbriche in Cina, i dipendenti arrivano a lavorare fino a 12 ore al giorno, con due sole pause, una sera libera a settimana e un giorno di riposo al mese, spesso senza contratto né previdenza o salari di base, pagati per ogni singolo capo prodotto e in stabilimenti dove non vengono rispettate le norme di sicurezza.
Un problema esteso anche al Bangladesh dove, secondo una ricerca pubblicata a gennaio scorso dall’Università di Aberdeen, su 1.000 fabbriche tessili quasi il 20% trova difficoltà persino a retribuire i propri dipendenti con il salario minimo previsto dalla legge, pari a 215 dollari al mese. Non solo: secondo l’Asia Foundation, nelle concerie e nelle tintorie industriali del Paese, i lavoratori non dispongono di dispositivi di protezione individuale, il che li espone a sostanze chimiche potenzialmente cancerogene. Una situazione anche peggiore per le donne, pagate meno dei loro colleghi maschi e a rischio abusi, anche sessuali. Secondo un rapporto del 2022 del britannico Modern Slavery & Human Rights Policy & Evidence Centre, la maggior parte delle impiegate nelle fabbriche tessili bengalesi sono giovani, scarsamente istruite e provengono dalle zone rurali più povere di un Paese in cui la tutela legale delle lavoratrici, anche contro la violenza di genere, resta tuttora limitata, così come le procedure per sporgere denuncia, che in molti casi vengono comunque ignorate.
La pandemia poi ha peggiorato tutto, come hanno raccontato alcune dipendenti di vari stabilimenti tessili cambogiani al progetto ReFashion, condotto in collaborazione tra le Università di Londra e Nottingham, nel Regno Unito. «Negli ultimi 10 anni, la situazione in fabbrica era migliorata ma ora è completamente cambiata. Dopo il Covid, il proprietario non rispetta più le leggi sul lavoro e ci paga solo metà stipendio. Quando abbiamo protestato, ha minacciato di sospenderci per due o tre mesi», ha detto una donna di nome Sophea, il cui salario minimo per legge dovrebbe essere di circa 190 dollari al mese. «Prima cucivamo 500-700 pezzi al giorno. Ora hanno fissato il target a 1.000 capi», ha rivelato un’altra donna di nome Pheakdei.
Ma è tutta una questione di potere, come ci spiega Deborah Lucchetti, coordinatrice nazionale della Campagna Abiti Puliti, sezione italiana dell’iniziativa internazionale Clean Clothes Campaign: «Nei Paesi di produzione tessile dove lo squilibrio di potere è profondamente radicato nelle disuguaglianze strutturali tra uomini e donne, le operaie non occupano posizioni di potere, sono confinate in ruoli subordinati, ancora più sottopagate degli uomini e sono spesso vittime di violenza e molestie nei luoghi di lavoro», spiega a TPI. «Anzi, è necessario riconoscere che la disuguaglianza di genere e la povertà lavorativa, generata da pratiche commerciali abusive e sleali in cima alla filiera, è una delle principali cause della violenza di genere. Le politiche di moderazione salariale adottate in tutti i Paesi di produzione tessile, Italia inclusa, unitamente alla femminilizzazione del settore, di fatto condannano alla povertà milioni di donne lavoratrici nel mondo».
Uno squilibrio che si riflette anche e soprattutto tra le aziende committenti e i fornitori dei Paesi poveri, che va allargandosi sempre più. Stando alla sopracitata ricerca dell’Università di Aberdeen infatti, in Bangladesh i principali marchi di moda sono accusati di pratiche scorrette nei confronti delle aziende da cui importano i propri capi: alcuni brand annullano gli ordini a produzione avvenuta, chiedono di ridurre il prezzo pattuito, si rifiutano di pagare la merce oppure ritardano il pagamento delle fatture. Tutto questo, secondo l’associazione britannica Transform Trade, viene poi scaricato sui lavoratori e sui salari perché il modo più semplice per le aziende locali di ovviare a questi problemi è tagliare i costi del personale e della sicurezza. Eppure queste sono esattamente le problematiche che l’International Accord for Health & Safety in the Textile & Garment Industry, raggiunto dopo il crollo del Rana Plaza, avrebbe dovuto risolvere.
Se basta una firma
Quest’ultimo è un insieme di accordi legalmente vincolanti conclusi tra i sindacati globali IndustriALL e UNI Global Union con vari marchi, rivenditori e ong internazionali per rendere le fabbriche tessili in Bangladesh e (dal 2023) in Pakistan luoghi di lavoro sicuri e salubri. «Si è rivelato estremamente efficace, in 10 anni sono state ispezionate più di 1.600 fabbriche, rendendole decisamente più sicure per 2,5 milioni di lavoratori», sottolinea Lucchetti. Ma c’è ancora molto da fare, come dimostra un episodio molto recente: «Il 13 aprile, un incendio di vaste proporzioni in una fabbrica tessile di Karachi (in Pakistan, ndr) ha provocato il crollo dell’edificio, causando la morte di 4 vigili del fuoco e il ferimento di altri 13», ci ricorda la coordinatrice della Campagna Abiti Puliti. «Questa fabbrica riforniva diversi marchi internazionali, dimostrando ancora una volta il fallimento dei meccanismi di controllo delle aziende e la necessità di adottare programmi di ispezione indipendenti».
Sono tanti infatti i problemi ancora da risolvere. «Parliamo di un sistema basato su salari di povertà, precarietà e lavoro informale, scarsa sindacalizzazione e capacità di contrattazione, violenze di genere, violazione sistematica dei diritti umani e sociali, orari estenuanti e lavoro forzato», prosegue Lucchetti. «Tutte questioni aperte, aggravate dalla crisi della pandemia e dalla crescita esponenziale di modelli di business sempre più aggressivi, come la ultra-fast fashion molto spinta dall’e-commerce».
Ad oggi, l’accordo per il Bangladesh è stato firmato da 195 marchi internazionali mentre in 45 hanno siglato anche quello per il Pakistan, comprese aziende come Asos, Adidas, H&M, Primark e Zara. Alcuni però sono ancora restii a impegnarsi: le multinazionali infatti non vogliono essere ritenute legalmente responsabili della sicurezza dei propri fornitori. E così 12 brand, tra cui aziende del calibro di Amazon, Ikea, Decathlon, Levi’s, Columbia, Wrangler e Lee, se ne sono tenuti fuori.
La Cina si avvicina
In Italia invece, sei grandi imprese hanno firmato gli accordi: Artsana (Chicco), Benetton, Prenatal, Oberalp (famoso il loro marchio Salewa), Armani (G.A. Operations, per una linea specifica di prodotti) e Ovs (che ha siglato anche quello per il Pakistan). Possono sembrare poche ma questo deriva dal fatto che il fenomeno della moda ultra-veloce non coinvolge la produzione del nostro Paese (sebbene conquisti ampi consensi tra i consumatori). «La moda italiana occupa la fascia alta del mercato per cui le lavorazioni dei Paesi di cui si nutre la Fast Fashion non sono interessanti», spiega a TPI Sonia Paoloni, membro della segretaria nazionale di Filctem-Cgil. «I brand di lusso del nostro Paese hanno sottoscritto tutti accordi per la tracciabilità della filiera, anche con sanzioni nei confronti dei terzi scoperti a violare le norme. Inoltre, i contratti nazionali firmati da Cgil, Cisl e Uil per l’industria della moda prevedono clausole anti-dumping, per cui è prevista la rescissione dell’accordo di fornitura in caso di mancato rispetto del Ccnl».
Eppure questo non esclude l’Italia dalla filiera dello sfruttamento, che può avvenire anche all’interno dei nostri confini nazionali. «Purtroppo, ci sono una serie di passaggi relativi alla sub-fornitura che possono sfuggire ai controlli», aggiunge Paoloni. «Se l’Alta Moda punta sulla professionalità e sul mantenimento di una filiera sicura e tracciabile all’interno del nostro Paese, anche entrando in compartecipazione con le imprese della catena di approvvigionamento, esistono anche situazioni da tenere sotto controllo, soprattutto a Sud, dove il caporalato continua a esistere».
Un problema che va ad aggiungersi alle aziende gestite da imprenditori stranieri. «Faccio l’esempio della Toscana, dove – non solo a Prato ma anche a Firenze – emergono storie di imprenditori di origine cinese che per abbassare ancora di più il costo del lavoro utilizzano manodopera proveniente dall’Asia e dall’Africa, più soggetta a ricatto perché senza documenti», prosegue la sindacalista. «Qui è difficile denunciare perché i lavoratori rischiano non solo di perdere reddito e impiego ma anche di essere espulsi. Per questo, sempre in Toscana, abbiamo raggiunto degli accordi con Confindustria e la Regione perché se un lavoratore denuncia possa poi avere la garanzia del permesso di soggiorno e di essere ricollocato».
Insomma qualcosa si muove e un’ulteriore buona notizia arriva dai tribunali: a inizio aprile, per la prima volta in Italia, un’impresa committente ha pattuito in sede civile il “risarcimento” di tre lavoratori stranieri impiegati da un’azienda di Poggio a Caiano, la cui titolare straniera è stata condannata per sfruttamento a un anno e dieci mesi di carcere. «È stata riconosciuta la responsabilità in solido del committente, che è il più grosso deterrente contro lo sfruttamento dei lavoratori», commenta Paoloni.
Inoltre entro novembre prossimo dovrà essere approvata anche la nuova direttiva europea sulla Corporate Sustainability Due Diligence, che imporrà alle grandi imprese di mitigare gli impatti negativi sull’ambiente, sulle condizioni di lavoro e sui diritti umani dell’attività dell’impresa lungo tutta la filiera. «Avrà un effetto dirompente», sostiene la sindacalista di Filctem-Cgil. Meno ottimista, in attesa del testo definitivo, Lucchetti: «Rischia di non riguardare la grande maggioranza delle imprese della moda, oltre a non dare risposte soddisfacenti su alcuni aspetti fondamentali come la regolazione delle pratiche di acquisto e le questioni di genere. Inoltre bisognerà capire se l’impianto sanzionatorio sarà sufficiente a scoraggiare condotte irresponsabili». Speriamo.